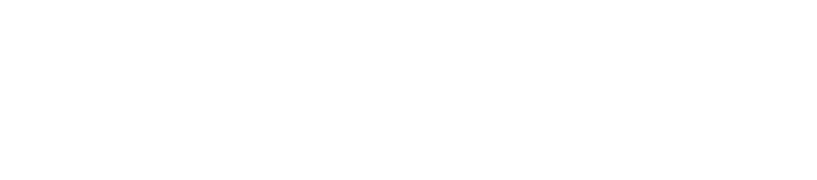C’è un sacerdote veneziano sconosciuto ai più, mons. Giovanni M. Gregoretti, che a distanza di un secolo e mezzo va invece riscoperto e ringraziato.
È don Gregoretti, infatti, che da arciprete parroco di San Pietro di Castello a Venezia nel 1853 apre un asilo per le “povere ragazze, vagabonde e pericolanti“, intitolato al Buon Pastore.
Nel 150° anniversario dell’avvio di quella realtà è il Patriarca che ricorda con gratitudine la figura del fondatore. Lo fa intervenendo, nella Scuola Grande di San Marco, venerdì 5 maggio mattina, al convegno promosso dall’Ipab Opere riunite Buon Pastore.
«Monsignor Giovanni Gregoretti – afferma il Patriarca – con quest’opera ha saputo immergersi nelle umane sofferenze di questa zona di Venezia – Castello – che è tuttora vivace e popolare».
Entrando più puntualmente nelle motivazioni che fecero sorgere l’istituzione, mons. Moraglia ricorda che «monsignor Gregoretti ha saputo avviare un’opera che è partita dai disagi e dalle necessità delle ragazze, soprattutto delle giovani abbandonate o in pericolo, oppure bisognose di assistenza e del bene grande e insostituibile dell’istruzione».
In questo senso l’antico parroco di San Pietro di Castello «ha confermato una bella tradizione di questa città e della Chiesa veneziana che, nei secoli, ha visto la presenza attiva ed innovatrice di numerosi presbiteri. Pensiamo a don Luigi Caburlotto, ai fratelli Cavanis e anche a don Luca Passi, che hanno contribuito a cambiare in meglio il volto della città e a renderla più umana e vivibile, più capace di risollevare e tenere alto il valore della dignità della persona, della libertà, prendendosi cura della vita dei singoli».
Ma le Opere riunite Buon Pastore non sono state una felice intuizione che hanno avuto valore solo nell’Ottocento; l’istituzione ha saputo evolvere e offrire un servizio sempre rinnovato, arrivando a garantire anche oggi una proposta adeguata ai bisogni del presente: «Ed ecco allora – conclude il Patriarca Francesco – le attuali iniziative, attività educative ed assistenziali dell’Ipab, che toccano la vita dei minori, dei giovani, delle famiglie, delle giovani mamme in difficoltà e dei loro figli ancora piccoli, del disagio, della disabilità e, comunque, dei disturbi dello sviluppo. E ancora: dei migranti e dei rifugiati e, infine, delle studentesse universitarie, che arrivano qui a Venezia e necessitano di ospitalità in vista di un sereno periodo di studio e formazione».